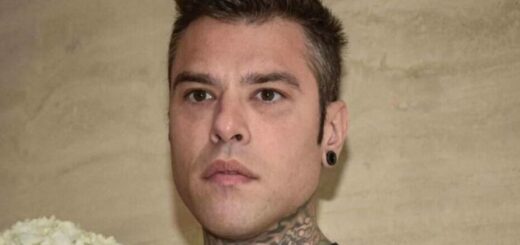Autarchia non è una parolaccia. L’autosufficienza economica da Platone a Mussolini

Roma, 24 mag – In tempi di coronavirus e conseguente impatto negativo del morbo sull’economia mondializzata, uno “spettro”, per parafrasare l’incipit del “Manifesto” di Marx ed Engels, si aggira tra le redazioni dei media mainstream e i think tank del pensiero globalista: quello dell’autarchia. Ne fa fede un articolo del Foglio che recensisce un intervento dell’editorialista del Financial Times Gideon Rachman («Nationalism is a side effect of coronavirus») in cui si paventa, come “effetto collaterale” del coronavirus, il ritorno in auge dello Stato nazione e, con esso, un rinvigorimento delle tendenze al protezionismo, alla localizzazione delle produzioni e alla chiusura delle frontiere, concludendo che, se tali istanze possono sembrare al momento giustificabili, non rappresentano le soluzioni migliori per il post-pandemia, poiché la rivitalizzazione dell’economia globale sarà più difficile se i singoli paesi si muoveranno secondo un’ottica di tipo “autarchico”.
Come è evidente, in questo come in altri articoli di analogo tenore, i termini protezionismo e autarchia (che non sono sinonimi, nel senso che l’adozione di misure protezionistiche è piuttosto funzionale all’attuazione di politiche autarchiche finalizzate a rendere autosufficiente uno Stato limitando gli scambi con l’estero e producendo da sé quanto prima ci si procurava tramite il commercio internazionale) sono caricati di connotazioni negative e associati a un quadro a tinte fosche di isolamento, esclusione e potenziale conflitto tra le nazioni. Il termine autarchia, in realtà, usato originariamente in filosofia nel senso etico (non economico) di condizione del saggio per il quale la felicità consiste nel “bastare a sé stesso”, non merita l’alone sinistro di cui il pensiero globalista tende a circonfonderlo.
Platone e l’autarchia della moneta
Il tema dell’autosufficienza economica ha, infatti, impegnato la riflessione di illustri pensatori sin dal tempo antico. Il greco Platone (V-IV sec. a.C.) nel dialogo “Repubblica”, volto a tracciare i contorni della “città ideale”, dedica per esempio uno spazio al tema del commercio con l’estero. Non si può dire che qui Platone si professi per un’autarchia integrale («[…] è pressoché impossibile fondarlo [lo Stato, cioè la polis] in un luogo che renda superflue le importazioni»); egli piuttosto insiste sulla necessità che, tramite un’oculata divisione del lavoro tra agricoltori, artigiani e mercanti, la produzione interna non solo soddisfi (in prima istanza) il fabbisogno interno, ma addirittura lo trascenda e crei dunque un surplus da utilizzare come merce di scambio per l’import di quei prodotti che non si possano ottenere in loco.
Più netta, invece, è la posizione pro-autarchia assunta dal filosofo nelle “Leggi”. Qui infatti, discutendo il tema della moneta di cui dovrà essere dotata la progettata colonia di Magnesia, si specifica che i cittadini potranno sì possedere del denaro, ma con la specificazione che tale moneta avrà corso legale solo all’interno della città e non nel resto della Grecia. Essa infatti (non a caso, non sarà di metallo nobile) avrà utilizzo solamente interno, come mezzo di scambio e per la retribuzione dei salariati, mentre l’esistenza di una riserva cittadina di “moneta internazionale” (in uso, cioè, nel resto della Grecia) non dipenderà da un suo impiego negli scambi internazionali (a cui il dialogo non accenna), bensì sarà legato solo agli eventuali bisogni di coloro che, per ragioni ufficiali come le ambascerie, dovranno recarsi all’”estero”.
Fichte e la chiusura dello Stato commerciale
Il tema autarchico ritorna, a cavallo tra Sette e Ottocento, negli scritti politico-economici di Johann Gottlieb Fichte, che vede nello Stato il fattore propulsivo di un ordinamento corporativo articolato in ceti professionali e impegnato nel perseguimento dell’autosufficienza economica. Uscendo dall’ottica liberale dello “Stato minimo” (mero tutore del diritto di proprietà), dell’economia di mercato e dell’apertura al commercio globale, il filosofo idealista propugna uno Stato “pianificatore e imprenditore” dove la chiusura commerciale con l’estero, collegata a un’organizzazione produttiva che renda fattibile (quando lo è) il soddisfacimento autonomo del fabbisogno nazionale di merci e di materie prime, sia il presupposto di una regolazione secondo giustizia della distribuzione del reddito e del prodotto interni.
Sono istanze, queste, da cui traspare la preoccupazione di quanto il commercio internazionale (con i suoi cicli e la sua imprevedibilità) metta un popolo a rischio di dipendenza dall’estero, onde per cui «sarebbe da raccomandare a ogni Stato di organizzarsi in modo da poter esso farne a meno» (“Fondamento del diritto naturale”, 1796-97), mentre, qualora ciò non fosse possibile per carenza di risorse interne, sarebbe opportuno garantirne perlomeno il monopolio da parte dello Stato stesso.
Nello “Stato commerciale chiuso” (1800) la proposta del blocco integrale al commercio estero viene così presentata da Fichte come un sistema conforme alla ragione, con l’auspicio che il cittadino, in esso, possa continuare a fruire degli stessi beni di cui godeva in tempi di commercio aperto, ma «nella misura in cui vengano prodotti o lavorati nel Paese dove abita». Fichte insiste qui sul fatto che il ripiegamento autarchico possa (e debba) avvenire innanzitutto per i prodotti lavorati, il che richiede un potenziamento (su impulso statale) della parte di apparato produttivo che possiamo definire industria di trasformazione per dare impulso alla fabbricazione autarchica di merci (o materiali) che sostituiscano quelli che, prima del “lockdown” commerciale, si reperivano sul mercato internazionale. Né si tratta, secondo il filosofo, di un compito impossibile, poiché «non è immaginabile nessuna causa per cui, ammesso che esistano le materie prime, ogni paese non sia in grado di fabbricare qualunque cosa e un popolo debba essere per natura così ignorante da non potere apprendere ogni arte meccanica fino a diventarne compiutamente esperto». Il tutto deve avvenire, precisa Fichte, nel quadro di una limitazione dei bisogni (cioè della domanda interna), da non intendersi però in termini pauperistici («non […] un far rinuncia a qualcosa, né un parco adattarci alla ristretta cerchia dei prodotti tradizionali del Paese»), bensì come spinta a un potenziamento produttivo conforme alle esigenze e alle risorse nazionali («un robusto appropriarci […] della parte che ci spetta di tutto ciò che di buono e di bello vi è sull’intera superficie della terra»). Un obiettivo, questo, con implicazioni geopolitiche significative, se è vero che lo Stato commerciale fichtiano, avendo bisogno di «un territorio esteso che contenga in sé un completo e conchiuso sistema della produzione necessaria», deve porsi il problema di far coincidere la propria estensione con i confini “economicamente naturali”; il che potrebbe implicare (ma non è detto che lo implichi), il ricorso alla forza militare, sebbene Fichte sottolinei come l’autarchia sarebbe piuttosto funzionale a una nuova era di distensione internazionale (la pacifica confederazione di libere repubbliche europee) in grado di evitare i conflitti causati dai contrastanti interessi mercantili tra gli Stati.
La “National Self-sufficiency” di Keynes
Un’apertura di credito alle istanze autarchiche, e più in generale protezionistiche, viene infine da John Maynard Keynes, nell’articolo del 1933 intitolato «National Self-Sufficiency». Come già in Fichte, così anche in Keynes l’opzione a favore dell’autosufficienza (“nazionalismo economico”) si colora di istanze etiche e politiche ispirate agli obiettivi della giustizia sociale e della pace, in quanto, secondo l’economista britannico, alla causa della distensione tra le nazioni sono più utili un elevato livello di autosufficienza e di isolamento economico di quanto possano esserlo «una grande concentrazione degli sforzi nazionali per conquistare i mercati esteri, [la] penetrazione, da parte delle risorse e dell’influenza di capitali stranieri, nella struttura economica di un paese e [la] stretta dipendenza della nostra vita economica dalle fluttuazioni delle politiche economiche di paesi stranieri».
L’appello keynesiano a «far sì che i beni vengano prodotti al proprio interno quanto più ragionevolmente e convenientemente è possibile» si accompagna alla segnalazione di quegli esperimenti politico-economici di tipo protezionistico o autarchico che, dalla Russia sovietica fino alla Germania, passando per Italia, Irlanda, Gran Bretagna e Stati Uniti, sembravano ispirati alla scelta di abbandonare, in tempi di crisi, i dogmi dell’internazionalismo economico.
L’Italia fascista: l’autarchia dalla teoria alla pratica
L’allusione di Keynes all’Italia non deve ovviamente stupire, nella misura in cui tra gli esempi storici di autarchia applicata rientra, com’è noto, la politica fascista nella seconda metà degli anni Trenta, la quale si inseriva a sua volta nel solco di provvedimenti già attuati sia prima che dopo la crisi iniziata nel 1929 in America (una crisi che vide prevalere, da parte degli Stati, un atteggiamento protezionistico in materia di politiche commerciali e che, in Italia, iniziò a essere avvertita già dall’inizio del decennio successivo).
Un occhio di riguardo ebbe infatti sin da subito il regime per l’agricoltura, considerata come importante “riserva economica”; un settore cioè che, in tempi di depressione, poteva garantire occupazione e reddito a coloro che non trovavano impiego nell’industria. Alla “battaglia del grano”, promossa nel 1925 per ridurre la necessità di importare cereali dall’estero (la quale fece sì che, nel 1934, il disavanzo costituito dalle importazioni di prodotti alimentari fosse quasi dimezzato), si aggiunse l’introduzione di dazi a protezione del settore agricolo (dal 1926), l’impulso ai lavori pubblici agricoli e alle bonifiche (tra fine anni venti e inizio anni trenta), la creazione di un mercato garantito basato sui consorzi agrari (1932). Con il varo delle sanzioni economiche legate alla guerra etiopica (novembre 1935), che colpivano l’import e l’export in settori significativi, la scelta autarchica del regime si impose quindi in tutta la sua evidenza, non tanto, questa volta, nel settore agricolo (che ormai copriva pressoché per intero il fabbisogno alimentare in campo cerealicolo e dove si ebbero peraltro ulteriori interventi significativi: dalla riorganizzazione agraria nel Tavoliere delle Puglie ai primi provvedimenti per la dissoluzione del latifondo siciliano), quanto in quello industriale, in cui, anche grazie al modello dell’IRI, l’obiettivo dell’autosufficienza (e dello sviluppo) fu perseguito ad ampio raggio (anche se con esiti alterni). Ci si adoperò, infatti, per uno sfruttamento intensivo delle risorse naturali nazionali tramite l’istituzione di agenzie ad hoc nei settori carbonifero (Acai, 1935) e metallifero (Ammi, 1936); per il potenziamento dell’industria idroelettrica (solo il 6% dei 15.544 Kwh prodotti nel 1938 era ottenuto dall’energia termica sprigionata da carbone e petrolio); per l’impulso al settore chimico (produzione di surrogati sintetici di tessili e minerali) e a quello dei combustibili, nel cui ambito si potenziò l’Agip (creata nel 1926 per promuovere lo sfruttamento petrolifero in Albania) e si istituì, nel 1935, l’Anic, al fine di ottenere carburanti liquidi dall’idrogenazione del carbone. Come si evince, dunque, da questa sommaria ricostruzione, l‘autarchia del fascismo, che in alcuni passaggi sembra ispirata alle concezioni di Fichte (riprese a sua volta da Keynes), iniziò ben prima delle “inique sanzioni” e non appare tanto motivata dalla fondazione di un’economia di guerra (la spesa bellica italiana conobbe un’impennata solo a partire dal 1939, alla vigilia del secondo conflitto mondiale) quanto da quella che Wolfgang Schivelbusch, in un saggio comparativo sulle politiche di Mussolini, Hitler e Roosevelt negli anni trenta, definisce politica di “colonizzazione interna” (di sviluppo infrastrutturale delle aree più arretrate) in un’epoca in cui, di fronte ai disastri della depressione, «l’autosufficienza economica nazionale», quell’autarchia tanto deprecata dal pensiero globalista, «era diventata la parola d’ordine del decennio».
Corrado Soldato