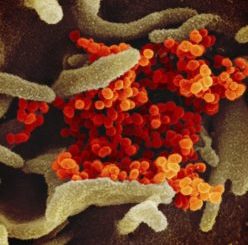I “mostri” nelle periferie, frutto dell’ideologia comunista e del “calcestruzzo rosso”

I mostri non sono generati solo dal sonno della ragione, ma anche dai suoi deliri di onnipotenza. L’architettura internazionalista sovietica ha contaminato – non a caso internazionalista – gran parte dei sonni di architetti di mezzo mondo, Italia inclusa, propensi all’incubo più che al sogno. Progettare appartamenti volutamente piccoli, ammassati gli uni agli altri, escludendo ogni forma di primitiva privacy, per “costringere” gli uomini a socializzare all’esterno – le Vele di Scampia, come il Serpentone del Corviale, o lo Zen di Palermo – è segno di un programma di “educazione sociale” che mette i brividi.
I danni dell’ideologia comunista nell’urbanizzazione
Nei giorni dell’abbattimento delle Vele di Scampia è inevitabile soffermarsi sulla città, sull’urbanizzazione compiuta e sulla necessità di una rigenerazione urbana depurata dall’ideologia, e dall’ideologia comunista in particolare.
L’esigenza di offrire una casa alle masse che dalle campagne e dal Sud si affrancavano dalla povertà alimentando i processi di urbanizzazione di quegli anni, costituiva una micidiale occasione per i cultori del socialismo reale. Il nostro Paese era preda – inutile negarlo – di una cultura fortemente penetrata dall’ideologia comunista, un po’ in tutti i settori. Il progetto gramsciano della conquista delle “casemate del potere” passava dalla cultura e della educazione. Che cos’è l’architettura se non educazione e potere? Progettare lo spazio della vita è esercizio di potere, sempre.
Il modello di edilizia intensiva
Non a caso l’architettura è stato uno degli ambienti di maggior esercizio di progetti e programmi “in linea” con le visioni di socializzazione derivate da un modello di vita e di aggregazione pensato più che da Marx, dai suoi epigoni in Russia, però quella che era ancora Unione Sovietica.
I grandi progetti di urbanizzazione dovevano coincidere con forme architettoniche e urbanistiche di collettivizzazione. Un modello di edilizia intensiva in cui categorie come il bello e l’umano venivano programmaticamente marginalizzate. Quando in questi giorni abbiamo visto abbattere le Vele di Scampia (tristemente famose per chi si occupa di architettura come il Corviale e Tor Bellamonaca a Roma o lo Zen a Palermo) non è apparso solo il fantasma di Gomorra, ma tutta l’incomprensibile stagione della costruzione di periferie che sarebbero diventate in pochissimo tempo sinonimo di degrado sociale prima ancora che abitativo. Già, le periferie. In quegli anni la distinzione tra centro e periferia coincideva con una differenziazione sociale, anche di censo, di status civile. I luoghi dell’abitare segnavano la differenza stessa tra centro e periferia. Perché c’era un centro e una periferia. E la periferia era il luogo dove si viveva peggio, il luogo anticamera della desolazione. Oggi è venuta a mancare questa topografia sociale. E spesso sono i centri storici a soffrire maggiormente del degrado urbano e urbanistico, della desolazione, dell’emarginazione reale di anziani e di soggetti deboli.
Il socialismo di calcestruzzo
Se non ci fossero stati i frutti del socialismo di calcestruzzo – come le Vele di Scampia – oggi le periferie non sarebbero per sé stesse sinonimo di degrado. Oggi se si parla, come si deve parlare, di “rigenerazione urbana” si deve parlare della città tout court. Di tutta la città. Forse di tutte le città. L’impatto demografico è tale che deve essere ripensato il modulo stesso della rigenerazione.
Quando se n’è parlato, tuttavia si è scelto di farlo con una visione statalista. I programmi di rigenerazione urbana finanziati negli ultimi anni dal Governo soffrono di alcuni problemi, diciamone almeno quattro.
Il primo: i soldi vengono messi a bando con una modalità rigorosamente centralista. Vengono adottati metodi standard, imponendo requisiti “nazionali”, che mal si attagliano alle differenze delle città italiane. Le idee di rigenerazione urbana non nascono quindi da una progettualità e da una visione della realtà cittadina, ma dall’esigenza di vincere un concorso, intercettando i punteggi fissati da una valutazione ministeriale. Ancora una volta – in Italia ne sappiamo qualcosa da un paio di secoli in qua – il Paese legale prevale sul Paese reale.
Il secondo problema di questo approccio statalista per bandi nazionali riguarda lo sguardo rivolto al patrimonio pubblico. La gran parte del patrimonio immobiliare delle nostre città è privato. I fondi per la rigenerazione urbana si rivolgono solo ed esclusivamente a quella modesta porzione di proprietà pubblica. Manca la capacità di innescare un processo complessivo, di feconda ibridazione tra pubblico e privato. Inevitabile ormai in tutte le dimensioni del vivere e dei servizi, ma evidente nella progettazione urbana, dove pubblico e privato sono fatti di mattone e di evidenza fisica non separabile. La leva finanziaria e quella urbanistica devono operare in sintonia sulla base di una strategia che restituisca valore, per quanto possibile, alla proprietà immobiliare. La casa, in Italia, ha cessato di essere un bene rifugio da almeno un decennio. La crisi finanziaria, il crollo del mercato edilizio e la patrimoniale imposta nel 2012 dal governo Monti, sono solo le principali cause di una dinamica che, al netto di alcune aree in cui l’edilizia ha tenuto, ha devastato la proprietà immobiliare. Rigenerare le Città deve poter significare anche intervenire su questo tessuto edilizio polverizzato e prevalentemente non riqualificato rispetto al quale le recenti iniziative dell’eco e del sisma bonus, pur apprezzabili, non hanno generato gli effetti attesi.
Il terzo problema si connette a queste ultime considerazioni ed evoca il concetto di sostituzione edilizia. Rigenerare vuol dire spesso la necessità di abbattere per ricostruire. Non bastano gli interventi solo manutentivi. Spesso ci vuole il coraggio di procedere a demolizioni, e poi a ricostruzioni. Questo è l’approccio necessario per salvaguardare le città da un degrado che deve essere contrastato con soluzioni che consentano alla qualità architettonica di abbinarsi alla sostenibilità energetica e alla sicurezza antisismica.
L’ultima questione, che forse è la prima per ordine di importanza, è la dimensione demografica: la rigenerazione urbana deve tener conto dell’attuale condizione i cui versa una nazionale in cui a fronte di 430.000 nati si registrano 645.000 decessi. In cui le esigenze abitative evolvono secondo le tendenze di nuclei familiari sempre più piccoli, spesso individuali, al contrario delle famiglie numerose che hanno caratterizzato l’Italia degli anni Sessanta e quindi dei modelli abitativi di allora. Un’Italia sempre più anziana e dove centinaia di paesi sono esposti al rischio spopolamento. Un’Italia in cui più del 70% degli abitanti è proprietario della casa in cui vive ma in cui 650.000 persone attendono l’assegnazione di una casa popolare.
Ecco, le politiche per la rigenerazione urbana dovrebbero essere una appendice di una strategia più ampia finalizzata alla rigenerazione di un’intera nazione che, ahimè, risulta ferma e sfiduciata.
Programma ambizioso. Progettualità tuttavia che non possono essere immaginate da lontano rispetto alla realtà di chi le vive. Anche i progetti di rigenerazione urbana devono poter corrispondere, infatti, a quell’esigenza di recupero di radici e di identità che è alla base di tanti fermenti positivi che affiorano in una società tradita dalle prospettive globaliste. Rigenerare le città vuol dire anche ricompattarle e favorire, all’interno delle stesse, le relazioni umane. E perché ciò accada questi processi devono essere gestiti e progettati coinvolgendo le comunità locali e consentendo ai comuni di svolgere un ruolo primario. Le comunità locali e i sindaci non possono non essere protagonisti della rigenerazione delle nostre città.