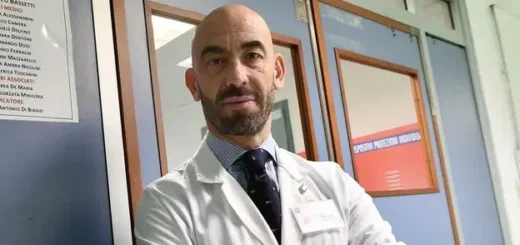Contadini, minatori, pescatori: gli italiani che hanno lasciato il segno in America

L’America degli italiani, l’America della Grande Mela, di Little Italy e di broccolino, l’Italia sbarcata a Ellis Island e quella dello star system, Sinatra e De Niro, Stallone e Di Caprio; l’America di Sacco e Vanzetti e di Fiorello La Guardia, di Toro Scatenato e di Joe Petrosino, del Padrino e della notte di San Valentino; l’Italia della lingua mista, mezza slang e mezza dialetto, «la mia jobba è bisinesse», «draivo il carro del bosso», la contaminazione delle parole prima della globalizzazione; l’Italia dei milioni di paisà partiti dalle campagne che neanche sapevano l’italiano, figuriamoci l’inglese; l’Italia d’America un po’ da cartolina, o da cartellone hollywoodiano, cialtrona e geniale, che si pensa in fondo sia tutta lì, con i suoi splendori e le sue miserie.
Invece c’è tutta un’altra Italia in America, nascosta e sconosciuta, dispersa in angoli che delimitano persino i confini della fine del mondo. Un’Italia fatta di piccole comunità lontane dalle rotte migratorie conosciute che ha piantato radici senza mai più perderle in North Carolina, Louisiana, Arkansas, Texas, che ha fatto diventare Italia lembi di prateria e vecchie piantagioni di cotone, trasformate, complice la lontananza e l’isolamento, in colonie del nostro Paese.
Paolo Battaglia, che è storico ed editore, è andato a cercare quelle tracce, seguendo passo passo più di un secolo dopo, le orme di quell’umanità di avventurieri e con loro quelle del barone Edmondo Mayor des Planches, che a dispetto del nome, lui che era francese di origini svizzere poi naturalizzato, fu ambasciatore italiano negli Stati Uniti di fine Ottocento. È il racconto delle migliaia di italiani che inseguivano il sogno «mericano» ma sulle strade più miserabili, quelle che portavano lontano solo perché non ci andava nessuno. Spiega Battaglia: «Gli italiani di Denver dicevano: ci avevano raccontato che qui c’erano strade lastricate d’oro, siamo arrivati qua e le strade non solo non erano d’oro, ma neanche c’erano. E abbiamo scoperto che le strade dovevamo costruirle noi»
E allora ecco il racconto che da Ellis Island va a Pittsburg in California, dove le vele dei pescatori siciliani di Isola delle femmine hanno trasformato fiumi e oceani in un industria della pesca, o di «Valdese», paese oggi di quattromila abitanti, fondato da protestanti piemontesi che trasferirono le loro comunità dalle Alpi alle Blue Ridge Mountains del North Carolina. Fino a Tontitown, creata da contadini veneti e emiliani guidati da un prete di Cesena, Pietro Bandini, che pare uscito da un fumetto di Tex, dopo la fuga dalla piantagione di Sunnyside in Arkansas. Racconta Battaglia: «A Tontitown arrivarono ai margini di quello che chiamavano Indian territory, il territorio dove vivevano ancora gli indiani, e siccome gli italiani stavano sulle scatole a tutti, gli anglosassoni della zona si travestirono da pellerossa per bruciare la chiesa e incolpare gli indiani. Don Bandini però, che aveva capito tutto, li avvisò: attenti che gli italiani escono tutti dell’esercito. Se tornate la prossima volta troverete pane per i vostri denti…» Non era vero. Erano tutti contadini portati lì per sostituire nelle piantagioni di cotone gli schiavi neri che non c’erano più. Li avevano convinti che lì avrebbero trovato terre meravigliose da acquistare, invece in quell’inferno ne morirono un centinaio in un anno. Morivano anche minatori, nelle company towns di Monongah in West Virginia e in ghost town come Dawson in New Mexico. Scriveva il barone: «Giunsero poveri, sfiniti, disprezzati, invisi; lavorarono, si dimostrarono onesti, parchi, perseveranti, ordinati. Comprarono dallo Stato terre mediocri, le migliorarono. Qualcuno andò sulle ferrovie o nelle miniere, ove il lavoro è duro ma il guadagno è forte. Ora non contano se non amici e sono ritenuti dagli americani la più brava gente del mondo». Lo scriveva in un libro che sarebbe rimasto polveroso come una prateria se Battaglia non solo non lo avesse riesumato ma se non avesse cercato, a suo modo folle come quegli italiani di frontiera, di andarli a cercare, più di un secolo dopo, per vedere la storia com’era finita, per sentire le voci di chi è rimasto, e tirarne fuori due libri e un documentario, per scoprire quanto sia italiana l’America, soprattutto quella più periferica, più italiana persino degli italiani stessi. «Trovare l’America», il primo, che ha la prefazione di Martin Scorsese, è figlio di tre anni di lavoro negli archivi della Libreria del Congresso di Washington, ed è diventato la più importante e completa visual history della presenza italiana negli States; il secondo, appena uscito «Italian American Country» è il racconto dei 25mila chilometri percorsi sulle strade americane, per incontrare i nipoti degli scalpellini anarchici della Toscana, dei contadini veneti sfuggiti alle piantagioni e dei pescatori siciliani dalla lingua incomprensibile. «Gli italiani sono ancora lì anche se di terza e di quarta generazione, antichi e moderni al tempo stesso. Sono rimasti italiani all’americana: hanno un’idea dell’Italia che non è al passo con i tempi e tradizioni religiosi più vicine a quelle novecentesche che di adesso. Anche il food è lo stesso ma riveduto e scorretto: per esempio la polenta con gli scoiattoli ha sostituito quella con gli osei…». Italiani come Kevin Pasquale, origini piemontesi e faccia da John Wayne, famiglia di contadini diventata di cowboy. Racconta di come gli italiani abbiano cambiato persino il panorama, costruendo nel Nevada zone in pietra, con mattoni italiani, il made in Italy forgiato dal sacrificio. «Adesso alcuni di loro sono andati altrove a vivere ma quando ci sono le ricorrenze tornano nella loro comunità come se fosse l’Italia, la loro Italia. È il loro modo di tornare a casa». Giusto o sbagliato, dicono in America, questo è il mio Paese.
il giornale.it