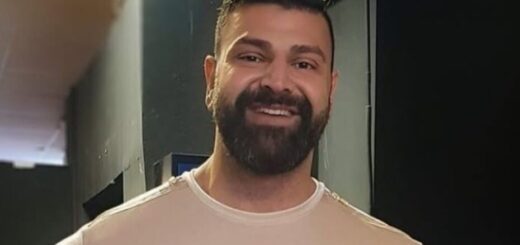La globalizzazione come “paziente zero”? Ce lo insegna la storia

Roma, 1 mar – «Per un glorioso trentennio, con la “globalizzazione”, un mondo artificiale, fantasmagorico e felice si è sovrapposto a quello reale. Si è pensato che fosse la fine della storia, il principio di una nuova geografia. Il Coronavirus segna il ritorno della natura, il passaggio dall’artificiale al reale, come reale è appunto un virus». Così Giulio Tremonti, in una recente intervista, ha messo in relazione la diffusione del Covid-19 con la globalizzazione[1], ponendo così il problema del legame di questa con la diffusione delle epidemie e riportando con i piedi per terra gli apologeti delle “magnifiche sorti e progressive” del mondo senza frontiere.
L’ideologia della globalizzazione e della “società aperta”
È ragionevole sostenere che il mondo globalizzato è particolarmente vulnerabile alle epidemie e dunque vedere nella diffusione del “virus cinese” una delle ragioni per mettere in discussione il modello globalista?
La “globalizzazione” è, innanzitutto, un processo concreto di espansione alla totalità del globo dell’economia di mercato nonché di «sistemi politici, tratti culturali e mezzi di comunicazione [con essa] coerenti»[2], ma non è solo questo. L’estensione planetaria dei modelli produttivi e di scambio dell’economia liberale e dei suoi corollari politico-istituzionali e mediatici (la “globalizzazione”) è infatti, per usare la terminologia di Marx, la struttura su cui si erge una sovrastruttura ideologica (il “globalismo”) fondata sull’esaltazione acritica di una società “aperta” (per dirla con Popper) non solo alla circolazione delle idee, ma soprattutto delle merci e della forza-lavoro (i “migranti economici” di qualunque tipo); una società, questa, spacciata peraltro quale antidoto al sovranismo, dipinto come fautore (per citare ancora Popper) del “tribalismo” e del “ritorno all’orda” delle società “chiuse”.
Considerazioni filosofiche a parte, è comunque difficile negare che, in un mondo globalizzato e condizionato dall’avversione per lo Stato-nazione (e per l’idea di frontiera), oltre che dall’ossessione per la libera circolazione di cose, denaro e uomini, gli «agenti infettanti […] viaggiano e circolano nel mondo come le persone e, se trovano le condizioni adatte, si insediano anche in ambienti nei quali prima non erano presenti»[3]. Il che accade più facilmente, come è ovvio, se la diffusione degli agenti patogeni è agevolata dall’erosione degli Stati nazionali (i sovrani che, secondo Schmitt, dovrebbero decidere sulle situazioni “di eccezione”) o da scelte di governo che pongono la sicurezza in secondo piano rispetto alla messa in dubbio dei dogmi, politicamente corretti, del libero scambio e della società accogliente.
In realtà, il nesso tra globalizzazione ed epidemie non è un problema solo contemporaneo, circoscrivibile ai contagi più recenti (Ebola, SARS, Coronavirus) o a quelli (come l’influenza spagnola) del secolo scorso, presentatisi in epoche in cui un “mondo interconnesso” si era già manifestato in tutta la sua evidenza. Vi sono precedenti storici più antichi, infatti, che agevolano la comprensione del legame sopra indicato, essendo possibile ritrovarvi analogie significative con l’oggi, al di là delle ovvie differenze di contesto.
Due eventi morbosi del passato risultano a tale proposito illuminanti: l’epidemia ateniese del V secolo a.C. e il contagio di peste che si abbatté sull’Europa intorno alla metà del XIV secolo.
La pestilenza di Atene
Nel 430 a.C., durante la guerra del Peloponneso e mentre era in corso l’invasione spartana dell’Attica, si diffuse ad Atene una malattia micidiale che in breve tempo uccise decine di migliaia di persone, al punto che lo storiografo Tucidide, a cui si deve una vivida descrizione del morbo nel suo resoconto del conflitto, riferisce di «un tale contagio e una tale strage [che] non erano avvenuti in nessun luogo a memoria d’uomo»[4].
L’aspetto che qui interessa della “peste di Atene” (per quanto ancora si dibatta sulla vera natura del morbo, che Tucidide chiamava semplicemente nosos, “malattia”) non è, ovviamente, né la sua ripercussione sul piano militare, né il lato propriamente epidemiologico, quanto la correlazione del contagio con le scelte politiche dei governanti di allora e, soprattutto, con la configurazione dell’economia ateniese, che rendeva la città attica ben più esposta al male della sua rivale Sparta.
Occorre infatti evidenziare, in primo luogo, la sciagurata scelta “accoglientista” dello stratego Pericle che, concentrando lo sforzo bellico ateniese nella guerra sul mare, evacuò le campagne dell’Attica invase dagli spartani, concentrando all’interno delle mura cittadine migliaia di rifugiati e trasformando così, scrive Victor David Hanson, la «città del Partenone e del teatro di Dioniso […] in un fetido campo profughi», dove la combinazione di calura estiva, sovraffollamento, scarsità di acqua e alloggi, inadeguatezza del sistema fognario creò le condizioni ideali per la diffusione del morbo[5]. In secondo luogo, il nosos descritto da Tucidide, come il coronavirus odierno, non era autoctono della Grecia, poiché «[…] la pestilenza veniva dall’Africa. Poi avrebbe viaggiato verso Nord, dall’Etiopia in Egitto e poi in Libia. Da lì si diffuse in varie parti dell’impero persiano prima di arrivare al Pireo [il porto di Atene]»[6]. Questa precisazione non è superflua per capire ampiezza e rapidità del contagio, se si tiene presente che, nel “microcosmo” del Mediterraneo orientale antico, Atene era una delle principali città marittime, particolarmente frequentata da viaggiatori e da mercanti, il che la rendeva «una calamita per un’ampia varietà di potenziali portatori di malattie, che durante la guerra non avevano ragione di frequentare altre città-stato eminentemente agricole [come Tebe, in Beozia, o la peloponnesiaca Sparta]»[7].
La “grande peste”: dall’Asia all’Europa
Oltre un millennio e mezzo dopo la diffusione del contagio ad Atene (e dopo altri episodi morbosi negli imperi romano e bizantino in età tardo-antica), colpì l’Europa bassomedievale un’epidemia di peste bubbonica, con un tasso di mortalità elevatissimo (il 90% dei soggetti colpiti non sopravviveva al contagio), causata da un bacillo trasmesso agli esseri umani dal morso delle pulci che, a loro volta, lo assorbivano dal sangue dei ratti di cui erano parassiti.
In questa epidemia, che tra il 1347 e il 1350 si diffuse in tutto il continente europeo provocando un tracollo demografico quantificabile in un terzo della popolazione, si riscontrano caratteristiche già individuate nel caso ateniese. Come sottolinea Adriano Prosperi, quasi a confermare il verso del Paradiso dantesco («Sempre la confusion de le persone/principio fu del mal de la cittade»), «dove c’erano centri di vita associata, il contagio era fulminante», mentre nelle campagne «dove la popolazione viveva isolata, gli effetti furono minori»[8]. L’Europa dopo il Mille, dove uno Stato moderno con il pieno controllo di confini e territorio era solo in embrione, aveva infatti conosciuto un vistoso sviluppo economico che, interagendo con l’aumento della popolazione, aveva provocato ingenti flussi migratori dalle montagne alle pianure e, soprattutto, dalle campagne alle città.
Come il germe che aveva assalito Atene, inoltre, anche il bacillo della peste bubbonica (identificato solo alla fine dell’Ottocento) era “allogeno”. Veniva infatti dall’Asia centrale, dall’odierno Kazakistan (dove furono testimoniati focolai nel 1338), colpì Astrakhan (Russia meridionale) nel 1346 e dal Mar Nero, sulle navi genovesi, sbarcò l’anno successivo a Messina, per dilagare in tutta Europa. Anche in questo caso, come in quello ateniese (sebbene in proporzioni immensamente maggiori), la fisionomia “globalizzata” dell’economia del tempo favorì l’epidemia. Fu infatti «il dinamismo della specie umana a dare al germe una nuova, enorme forza distruttiva» nella misura in cui il bacillo della peste fu trasportato dagli uomini «sulle loro navi e sulla loro stessa pelle, alloggiandolo e tendendolo al caldo con le pulci che lo trasmettevano [laddove invece] i topi non avrebbero mai superato i deserti e le steppe dell’Asia centrale per spingersi verso l’Europa; e certamente non avrebbero mai traversato il Mediterraneo»[9].
L’interscambio globale di uomini e merci tra Asia ed Europa fu dunque il veicolo dell’infezione che falcidiò gli abitanti del Vecchio Continente? Prosperi, nella sua ricostruzione storica della peste trecentesca, non ha dubbi: «le vie commerciali di un’Europa dalla rinnovata e fiorente vita economica e sociale sono le stesse su cui viaggia il nemico invisibile; l’espansione e i rinnovati contatti tra i popoli portano con sé pericoli inauditi [e] l’unificazione tendenziale del mondo [può causare] incontri imprevisti con le capacità distruttive di nemici invisibili e sconosciuti», anche perché «infezioni tipiche di un’area determinata nella quale la popolazione aveva sviluppato nel tempo difese batteriologiche più forti, colpirono popoli nuovi, impreparati, con effetti micidiali»[10].
La libera circolazione dei virus
Se la storia, come insegna Cicerone, non è solo “vita della memoria”, ma anche “maestra della vita”, gli entusiasti della società “aperta” e del pianeta no borders dovrebbero trarre qualche ammaestramento dal passato. Senza pretendere un ritorno alla chiusura autarchica del sistema curtense, occorre ammettere che, in assenza di frontiere e di Stati che le presidiano con pienezza di poteri di argine e controllo, la libera circolazione “ovunque di tutto e tutti”, per citare Diego Fusaro, implica necessariamente anche la libera circolazione dei virus.
Corrado Soldato
[1] https://www.ilgiornale.it/news/mondo/coronavirus-tremonti-schiaffo-dellepidemia-globalizzazione-1825447.html
[2] Luciano Gallino, Dizionario di sociologia, Torino, 2004
[3] https://www.avvenire.it/attualita/pagine/clima-e-globalizzazione-pi-malattie-infettive
[4] Tucidide, La guerra del Peloponneso, Milano, 2009
[5] Victor Davis Hanson, Una guerra diversa da tutte le altre. Come Atene e Sparta combattevano nel Peloponneso, Milano, 2005
[6] Hanson, op. cit.
[7] Hanson, op. cit.
[8] Adriano Prosperi, Storia moderna e contemporanea. Volume Primo. Dalla Peste Nera alla Guerra dei Trent’anni, Torino, 2000
[9] Prosperi, op. cit.
[10] Prosperi, op. cit.